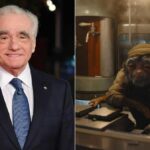Anemone: il toccante ritorno di Daniel Day-Lewis in un dramma familiare tra memoria, colpa e fragili legami.
A otto anni dal suo silenzioso addio con Il filo nascosto, Daniel Day-Lewis torna sullo schermo in modo del tutto inaspettato con Anemone, un dramma familiare intimo e toccante, scritto a quattro mani con il figlio Ronan Day-Lewis, qui al suo debutto come regista.
Ambientato nei paesaggi nebbiosi e sospesi del nord dell’Inghilterra, Anemone, presentato nella sezione Alice nella Città alla Festa del Cinema di Roma 2025, è il frutto di una collaborazione profondamente personale, con un padre che torna davanti alla macchina da presa per sostenere il figlio in un commovente passaggio di testimone dall’approccio riflessivo, lontano dalle logiche dei grandi studi e dal rumore del mercato.
Tra silenzi e ferite mai chiuse, lentamente, si torna a vivere
Anemone è una storia fatta di silenzi, colpe taciute e legami spezzati, il cui cuore pulsa attorno alla memoria, al peso del passato e alla possibilità – forse – di una riconciliazione. Sean Bean interpreta Jem, un uomo disilluso e consumato da una colpa mai confessata, che lascia la periferia grigia per ritrovare il fratello maggiore Ray, che ha scelto l’isolamento in una casa tra i boschi. Ed è qui che riappare Daniel Day-Lewis, dal volto segnato dalla distanza, dai traumi, dal dolore e da quel rancore sordo che spesso si annida nei rapporti più profondi.
Tra dialoghi non detti e emozioni trattenute, Anemone scava nelle crepe di una famiglia lacerata, raccontando con delicatezza come, a volte, l’unico modo per ritrovarsi sia perdersi ancora una volta. La memoria diventa così un campo minato, dove ogni ricordo può risvegliare antiche ferite o provocare nuove incomprensioni, con il passato che continua a influenzare ogni scelta.
Anemone non offre spiegazioni chiare o tradizionali; non ci sono rivelazioni forti, ma solo silenzi eloquenti, che invitano lo spettatore a cogliere ciò che accade tra le righe, in ciò che non viene detto apertamente, in ciò che si nasconde come il bosco dove si svolge gran parte della storia, simbolo di uno spazio fuori dal tempo, dove la natura riflette la fragilità dei personaggi, e ogni dettaglio – dal ramo spezzato al passo nell’erba bagnata, all’alito di vento – sembra riportare a galla ciò che è stato represso.
Jem e Ray, infatti, non si incontrano per guarire le ferite, ma per riconoscere un dolore che non può più essere nascosto, e in quel semplice gesto del restare — senza parole, senza fuga — si cela un atto di coraggio e affetto. Il loro incontro non è liberatorio né risolutivo, ma teso e trattenuto. Non c’è una vera riconciliazione, ma un lento e difficile tentativo di stare di nuovo insieme. Le parole sono poche, i gesti parlano al loro posto, e ciò che conta non è il perdono, ma imparare a convivere con il dolore, invece di evitarlo.
Un intreccio di relazioni fragili e ricordi fa da sfondo al ritorno intenso e misurato di Daniel Day-Lewis, straordinario nel dare vita a un uomo che ha scelto l’isolamento come rifugio. Un uomo che comunica più con lo sguardo che con le parole e nel cui mondo di precisione e controllo ogni gesto si carica di significato. La sua presenza, pur senza mai imporsi, modifica l’atmosfera, trasformando il silenzio in emozione pura.
Come un fiore di anemone, Ray è delicato, vulnerabile, e si ritrae al minimo contatto emotivo; le sue cicatrici lo rendono chiuso, incapace di lasciarsi davvero avvicinare. Eppure, quando smette di opporre resistenza e si abbandona, riesce finalmente a mostrarsi per ciò che è: un uomo capace di amare, ma solo nel momento in cui accetta la propria fragilità. In questa tensione sottile tra distanza e intimità, tra forza e bisogno, si svela tutta la complessità del suo personaggio.
Fragilità che racchiude l’essenza del film e si esprime appieno nel finale, che non ha bisogno di grandi dimostrazioni: basta un’azione semplice, concreta, profondamente umana, per far comprendere che il perdono è possibile. Un gesto autentico, capace di rivelare che, anche dopo un lungo periodo di chiusura e solitudine, si può tornare a vivere.
Ma attenzione: Anemone non si appoggia al peso del suo nome. La regia di Ronan Day-Lewis, al suo primo film, è sobria e attenta ai dettagli. Cresciuto tra Irlanda e Inghilterra, dove ha coltivato la passione per scrivere e dirigere lavorando in ambienti indipendenti e piccoli teatri, prima di realizzare questo progetto intimo ma ambizioso, Ronan lascia spazio ai corpi e ai paesaggi, facendo avvertire – anche nei momenti più lenti – il desiderio di sincerità, nonché la relazione tra padre e figlio che, pur non esplicitata, attraversa il film come una corrente sotterranea. Non ci sono autocelebrazioni, ma un dialogo intimo fatto di sguardi condivisi, fiducia reciproca e profondo rispetto artistico, con il cinema che si fa linguaggio comune tra due generazioni.
Il peso del non detto
Privo di enfasi e a tratti ostico, Anemone procede per sottrazione, richiedendo allo spettatore attenzione e pazienza, e chi saprà ascoltarne il ritmo troverà un racconto stratificato sul dolore e sulla possibilità di rielaborarlo.
La fotografia di Ben Fordesman, in widescreen, mostra con precisione il grande paesaggio e la piccola presenza delle persone. Il suono è minimo ma molto efficace: il fruscio degli alberi, i passi sull’erba e i momenti di silenzio contribuiscono a raccontare la storia.
Anemone è un debutto notevole e potente, non tanto per le sue ambizioni quanto per la sincerità con cui affronta temi complessi. Ronan Day-Lewis entra nel grande cinema con una voce personale e autorevole, seppur ancora in via di definizione. Anemone è un film che lascia segni profondi e ha il coraggio di non voler piacere a tutti. E il ritorno di Daniel Day-Lewis è un tassello di un mosaico più ampio, che parla di legami universali: perdite e tentativi di comprensione.
©Riproduzione Riservata
Emanuela Giuliani
Il Voto della Redazione: