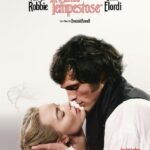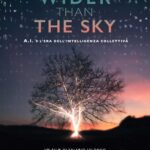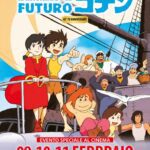C’era una volta in America: capolavoro di Leone su amicizia, tradimento e memoria, un viaggio tra sogno, rimpianto e nostalgia senza tempo.
Con C’era una volta in America (1984), Sergio Leone raggiunge la vetta della sua arte e si congeda dal cinema con un’opera monumentale. Dopo oltre dieci anni di silenzio, il regista abbandona il western, genere che lo aveva reso celebre, per raccontare una storia di amicizia, tradimento e rimorso ambientata nell’America del Proibizionismo. Ispirato al romanzo The Hoods di Harry Grey, il film segue quarant’anni della vita di David “Noodles” Aaronson (Robert De Niro), dalla giovinezza nel ghetto ebraico di New York fino alla vecchiaia, quando il passato si presenta come un fantasma inevitabile.
Leone trasforma quella che potrebbe sembrare una semplice vicenda criminale in una riflessione profonda sul tempo e sulla memoria. La narrazione procede per salti temporali, alternando presente e passato secondo la logica del ricordo piuttosto che quella cronologica. Tutto sembra nascere dalla mente del protagonista, come un sogno che si fonde con la realtà o una lunga allucinazione d’oppio, dove la memoria appare fragile e ingannevole. Il tempo, per Leone, non è lineare ma circolare: ogni immagine diventa frammento di una vita che si ripete, rivive e svanisce, trascinando lo spettatore in un flusso ipnotico e condividendo con Noodles la malinconia di chi scopre, guardando indietro, che il passato non finisce mai davvero.
Amicizia, tradimento e disillusione
Il cuore del film è l’amicizia tra Noodles e Max (James Woods), due ragazzi legati dall’emarginazione e dal desiderio di riscatto. Fin dall’infanzia, la loro fratellanza rappresenta un rifugio contro la miseria e la violenza delle strade, ma crescendo quel legame si trasforma in terreno di scontro: Noodles resta ancorato alla lealtà e al codice d’onore del passato, mentre Max incarna l’ambizione sfrenata e la spinta verso il potere. La loro relazione, fondata su fiducia e rispetto, si corrompe lentamente sotto il peso del denaro e della violenza, fino a culminare nel tradimento che segna la rovina di entrambi.
Attraverso questa amicizia, Leone costruisce una tragedia morale sulla perdita dell’innocenza e sul fallimento dei sogni giovanili. I due non sono più padroni del proprio destino: diventano prigionieri di un mondo che divora chi cerca di dominarlo. La loro storia diventa così una potente metafora della disillusione americana, in cui il desiderio di grandezza si trasforma in rovina. In questo senso, il film si ricollega idealmente ai precedenti capolavori di Leone – C’era una volta il West e Giù la testa – componendo una sorta di “trilogia del tempo”, in cui il sogno di progresso e libertà mostra inevitabilmente la sua degenerazione. Qui, il sogno americano non è un ideale da inseguire, ma un inganno che conduce alla solitudine e al rimpianto.
Deborah e l’amore impossibile
Nel percorso di Noodles, Deborah (Elizabeth McGovern) rappresenta l’unico spiraglio di purezza e di aspirazione a qualcosa di più alto. Fin da bambina sogna una vita diversa, lontana dal ghetto e dalla violenza: studia danza, recita Shakespeare davanti allo specchio e crede nell’arte come forma di libertà. Per Noodles, che la osserva in silenzio da dietro una porta, Deborah diventa l’incarnazione del sogno stesso: qualcosa di bello ma irraggiungibile, come l’America che entrambi inseguono in modi diversi.
Il loro amore è destinato a fallire, perché appartengono a due mondi inconciliabili. Noodles, incapace di esprimere i propri sentimenti, finisce per distruggere ciò che ama, trasformando il desiderio in violenza. La scena dello stupro nella limousine resta il momento più devastante del film, e Leone la filma con una freddezza quasi rituale, a mostrare la frattura definitiva tra amore e brutalità. Da quel momento, Deborah smette di essere una presenza reale e si trasforma in un simbolo: un ricordo idealizzato che perseguita Noodles per tutta la vita. In lei si concentra il tema della memoria come punizione: non è solo il ricordo di un amore perduto, ma l’immagine di ciò che Noodles non è stato capace di essere. La sua assenza, negli anni della vecchiaia, pesa più della sua presenza: il tempo non guarisce, ma amplifica la colpa.
La visione poetica di Leone
Il film è una delle opere più complesse e raffinate della storia del cinema. Leone concepisce ogni scena come un quadro vivente, in cui composizione visiva e ritmo narrativo diventano strumenti per evocare emozioni più che per descrivere azioni. La macchina da presa si muove lentamente, come se esplorasse i ricordi; gli sguardi dei personaggi, i gesti sospesi e i lunghi silenzi creano un linguaggio fatto di attese e assenze.
La fotografia di Tonino Delli Colli accentua questa poetica: la luce calda e dorata dell’infanzia contrasta con i toni spenti e metallici della maturità, restituendo visivamente il conflitto tra sogno e disillusione. Le strade di New York, filmate tra Cinecittà e i quartieri reali del Lower East Side, appaiono come un luogo sospeso nel tempo, a metà tra realtà storica e visione onirica.
La colonna sonora di Ennio Morricone amplifica ulteriormente questa dimensione emotiva. I temi musicali – malinconici, struggenti, circolari – non accompagnano semplicemente le immagini, ma ne diventano la voce più profonda. Deborah’s Theme è il suono della nostalgia, Poverty quello dell’infanzia perduta, mentre Amapola scandisce i momenti in cui amore e ricordo si intrecciano fino a confondersi. L’unione tra immagini e musica crea una sinfonia emotiva in cui ogni nota e ogni inquadratura sembrano parlare la stessa lingua.
Il risultato è un film in cui il tempo cinematografico si trasforma in tempo interiore: un viaggio nella memoria che non appartiene solo al protagonista, ma a chiunque guardi. Leone, più che raccontare, evoca; più che mostrare, fa ricordare. È il suo film più intimo, dove il mito si dissolve nel sentimento umano e la nostalgia diventa la vera protagonista.
Il finale e l’eredità
Il finale resta una delle conclusioni più ambigue e poetiche del cinema moderno. Noodles, ormai anziano, incontra Max dopo decenni di silenzio: l’amico che credeva morto vive sotto falsa identità, ricco e rispettabile. La loro conversazione è un addio carico di rimpianto, un momento in cui il passato sembra tangibile ma irrimediabilmente perso. Noodles rifiuta la vendetta e sceglie il silenzio, lasciando Max al suo destino: un gesto di saggezza, ma anche di impotenza, consapevole che il tempo non restituisce nulla.
Quando lo vediamo infine nella fumeria d’oppio, con un sorriso enigmatico, il film si chiude su un’immagine sospesa. Quel sorriso può significare pace, follia o oblio, ma soprattutto rappresenta la resa al tempo: l’accettazione che la vita, come il sogno, è destinata a svanire. Leone lascia aperta la possibilità che tutta la storia sia un ricordo oppiaceo, un viaggio mentale di Noodles nel tentativo di perdonarsi.
La storia produttiva del film è essa stessa leggendaria. Leone impiegò oltre dieci anni per sviluppare il progetto, e la sua versione originale, lunga più di quattro ore, fu mutilata dalla distribuzione americana, che la ridusse a un film lineare e privo di senso. Negli Stati Uniti fu un fallimento, mentre in Europa l’opera venne accolta come un capolavoro. Solo con il restauro del 2012, presentato a Cannes, C’era una volta in America ha ritrovato la forma autentica pensata da Leone.
Oggi il film è riconosciuto come una delle più grandi opere del Novecento, non solo per la perfezione visiva, ma anche per la capacità di parlare dell’uomo, della memoria e del rimorso. Noodles, nel suo sorriso finale, sembra portare anche il volto di Leone: l’autore che, guardando la fine del proprio percorso, trasforma la nostalgia in poesia e affida al cinema l’unico modo possibile per sopravvivere al tempo.
©Riproduzione Riservata
Emanuela Giuliani