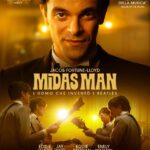Dal romanzo di Emily Brontë al cinema: Cime Tempestose tra amore ossessivo, paesaggi selvaggi e adattamenti che ne rinnovano la forza.
Nel cuore delle brughiere del nord dell’Inghilterra, tra cieli plumbei e venti impetuosi, prende forma una delle storie più intense, torbide e inquiete della letteratura occidentale: Cime tempestose.
Pubblicato nel 1847 da Emily Brontë sotto lo pseudonimo maschile Ellis Bell, è un romanzo che ha sempre diviso i lettori: da un lato adorato come un capolavoro romantico, dall’altro rifiutato per la sua brutalità emotiva e per l’assenza di eroi positivi. In realtà, proprio questo suo carattere estremo è ciò che gli ha permesso di attraversare i secoli senza perdere forza. L’amore tra Heathcliff e Catherine non è mai idealizzato, né redento: è piuttosto un legame viscerale, primitivo, destinato a distruggere tutto ciò che tocca, incluso se stesso.
A rendere questo romanzo così particolare, e per certi versi rivoluzionario per l’epoca vittoriana, è la sua struttura narrativa stratificata, che alterna voci e punti di vista, e la sua ambientazione aspra, che non fa da semplice sfondo ma partecipa emotivamente alla vicenda. Dalle brughiere, al vento che fischia attorno a Wuthering Heights, alle tempeste che sradicano alberi e certezze, tutto parla la stessa lingua dei personaggi, fatta di tormento, desiderio, rancore e perdita.
Oggi Cime tempestose continua a incantare e a inquietare proprio per la sua natura irrisolta, che si rifiuta di essere classificata, romantica e gotica insieme, tragica e passionale, feroce ma a suo modo lirica.
L’amore come rovina, la natura come specchio, il tempo come prigione
Il cuore tematico del romanzo ruota attorno a un amore che non è mai consolazione o appagamento, ma piuttosto una condanna. Heathcliff e Catherine non si amano per ciò che sono, ma per ciò che rappresentano l’uno per l’altra: sono carne e spirito della stessa essenza, eppure si dilaniano nel tentativo di riconoscersi. Quando Catherine sceglie di sposare Edgar Linton, pur dichiarando che il suo vero amore è Heathcliff, la ferita che ne deriva è insanabile, e Heathcliff, umiliato e respinto, non perdona, il sentimento si trasforma così in vendetta, e la passione che avrebbe potuto salvare finisce per distruggere. È un amore che brucia tutto.
Ma Cime tempestose è anche un romanzo sull’identità e sull’emarginazione ed Heathcliff è l’estraneo per eccellenza: orfano di origini oscure, forse zingare, accolto con riluttanza nella famiglia Earnshaw e poi spogliato di ogni appartenenza, con la sua rabbia che nasce anche da un mondo che non gli concede dignità. La sua ascesa sociale, costruita sul rancore e sul desiderio di dominare chi un tempo lo ha schiacciato, non è un riscatto morale, ma piuttosto la vendetta di un reietto che ha imparato le regole della crudeltà.
In questo contesto il paesaggio gioca un ruolo fondamentale nella narrazione, con le brughiere del Yorkshire che oltre ad essere lo scenario in cui si muovono i personaggi, sono anche una vera e propria estensione della loro interiorità. Quando Catherine corre tra le colline spazzate dal vento, è come se cercasse di ritrovare se stessa nella furia della natura, la casa di Cime Tempestose, esposta alle intemperie, rappresenta lo spirito selvaggio, indomito, violento, mentre Thrushcross Grange è il luogo della compostezza e dell’ordine, ma anche della repressione. La natura quindi detta le leggi più della società, e l’animo umano sembra sempre sul punto di soccombere alla propria animalità.
Un altro elemento centrale è il tempo. Il romanzo è strutturato come una serie di racconti nel racconto, affidati a narratori che osservano, riferiscono, interpretano. Questo gioco di specchi non è solo un espediente stilistico: è un modo per mostrare come il passato non passi mai davvero, con i peccati dei padri che ricadono sui figli, e le passioni che non si dissolvono, ma si incarnano in nuove generazioni. La storia tra Catherine e Heathcliff si riflette in quella tra i loro discendenti che cercano, spesso inconsapevolmente, di spezzare il ciclo della sofferenza, e forse, in quel tenue spiraglio finale, si può intravedere una possibilità di redenzione, anche se mai totale.
Tra fedeltà, reinterpretazione e rischio
Tradurre Cime tempestose in immagini è sempre stato un compito arduo, dal momento che la forza del romanzo sta nella sua tensione emotiva, nei silenzi carichi di significato, nella psicologia dei personaggi più che nella trama in sé. Per questo, ogni adattamento ha dovuto compiere scelte nette: privilegiare l’aspetto romantico, quello gotico, quello psicologico, o magari concentrarsi solo su una parte della storia. Non tutte le versioni di fatto coprono l’intero arco narrativo, e molte si fermano alla morte di Catherine, lasciando da parte la generazione successiva, probabilmente perché meno iconica, o meno comprensibile fuori dal contesto letterario.
La trasposizione del 1939 diretta da William Wyler è considerata un classico del cinema hollywoodiano. Interpretata da Laurence Olivier e Merle Oberon, è elegante, drammatica, ma anche molto più “addomesticata” rispetto al romanzo: i lati più oscuri dei personaggi vengono smussati, e l’amore tra Cathy e Heathcliff è rappresentato in chiave più romantica che ossessiva. Nel 1992 Peter Kosminsky tenta un adattamento più fedele, affidando i ruoli principali a Ralph Fiennes e Juliette Binoche, cercando di restituire la potenza tragica dell’originale. Tuttavia, è soprattutto la regista Andrea Arnold, nel 2011, a proporre una versione radicalmente diversa: quasi priva di dialoghi, con una fotografia cruda, terrosa, e un Heathcliff interpretato da un attore nero, scelta che riprende il possibile sottotesto razziale del romanzo e ne accentua il senso di estraneità.
Nel corso degli anni, ci sono state anche trasposizioni più libere, come Sparkhouse del 2002, che reinventa la storia in chiave contemporanea, invertendo il genere del protagonista, o Wuthering High School del 2015, ambientata in un liceo americano, dove i protagonisti diventano adolescenti problematici. Esperimenti questi che, pur allontanandosi dal testo, dimostrano quanto Cime tempestose continui a parlare a ogni epoca, purché si abbia il coraggio di reinventarlo.
Ed è proprio questo che promette di fare Emerald Fennell con la sua attesissima versione cinematografica, prevista per il 2026, che promette di essere intensa e radicale. Dopo i suoi lavori provocatori come Promising Young Woman e Saltburn, la regista ha annunciato che resterà fedele alla lingua di Emily Brontë, mantenendo molti dialoghi originali, ma darà al film un tono sensuale e viscerale, quasi disturbante. Margot Robbie sarà Catherine, Jacob Elordi Heathcliff: un casting che ha suscitato polemiche, e che Fennell ha difeso parlando di un’interpretazione più estetica che politica, focalizzata sul dolore fisico e psichico dell’amore assoluto.
Il film si concentrerà sulla prima parte della storia, fino alla morte di Catherine, privilegiando l’intensità emotiva e l’impatto sensoriale. Le prime immagini, brughiere cupe, corpi in estasi e in agonia, musiche contemporanee su costumi d’epoca, lasciano intuire un’opera che non intende semplicemente adattare il romanzo, ma farlo esplodere nel linguaggio visivo del cinema più estremo.
L’amore che brucia ancora
Cosa rende Cime tempestose così difficile da dimenticare? Forse il fatto che non offre conforto, né modelli da imitare. È un romanzo che parla d’amore non come salvezza, ma come condanna. Un amore che lega e soffoca, che rende ciechi, che genera morte, eppure, proprio per questo, continua a esercitare un fascino potente. Nel mondo contemporaneo, dove le relazioni sono spesso narrate come ricerca di equilibrio, Brontë ci ricorda che l’amore può anche essere abisso, perdita di sé, desiderio di annullarsi nell’altro.
Le trasposizioni cinematografiche, con tutti i loro limiti, cercano di restituire questo nodo emotivo, ognuna a modo suo: chi esaltando la bellezza tragica, chi scavando nel dolore, chi reinventando completamente il contesto. Ma in fondo, Cime tempestose è un canto selvaggio contro ogni forma di misura, e ogni nuova versione non fa che riaffermare la sua urgenza perché in un mondo che cerca sempre la pace, raccontare la tempesta è ancora necessario.
©Riproduzione Riservata
Emanuela Giuliani