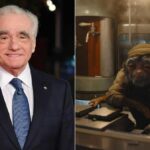DogMan di Luc Besson: la solitudine, la fede e la rinascita di un’anima ai margini in un dramma intenso e visivamente potente.
Luc Besson il regista di Léon, Nikita e Il quinto elemento, nel 2023 con DogMan firma uno dei film più intensi della sua carriera, che è insieme dramma, noir e favola tragica. Un ritorno alle sue radici più intime e visionarie segnato da un periodo complesso della sua vita, che ha profondamente influenzato DogMan, sia nella scelta di temi oscuri e dolorosi sia nel ritorno a un cinema più personale e simbolico.
Le vicende personali e le critiche subite hanno infatti spinto Besson a concentrarsi sulla marginalità, la solitudine e la redenzione, trasformando la storia di Douglas in un riflesso quasi autobiografico di una ricerca di autenticità e di riscatto artistico.
Presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia, DogMan ha immediatamente diviso critica e pubblico, come spesso accade con i film di Besson. Da un lato, è stato elogiato per la sua potenza visiva e per la straordinaria interpretazione di Caleb Landry Jones; dall’altro, accusato di eccessiva teatralità e di un simbolismo fin troppo esplicito. Eppure, al di là delle opinioni contrastanti, DogMan è un film che non lascia indifferenti: un racconto struggente sulla diversità, l’emarginazione e la capacità dell’amore di sopravvivere anche nel dolore più profondo
La solitudine, la fede e la rinascita di un’anima ai margini
Sospeso tra realismo e allegoria, Luc Besson sceglie di ambientare DogMan in una città americana senza nome, grigia, desolata, anonima: un luogo che potrebbe trovarsi ovunque, perché rappresenta tutte quelle periferie del mondo dimenticate, in cui finiscono i rifiuti, materiali e umani. Le strade deserte, i locali squallidi e i magazzini abbandonati formano un paesaggio urbano decadente, in cui la presenza umana è ridotta al minimo e la vita sopravvive solo ai margini.
Una sensazione di isolamento accentuata dalla fotografia fredda e metallica rende la città non solo uno sfondo, ma un vero e proprio riflesso psicologico del protagonista: Douglas, un uomo costretto su una sedia a rotelle, sopravvissuto a un’infanzia di abusi e a una società che lo ha escluso. Il suo rifugio è un capannone industriale trasformato in una sorta di santuario popolato da cani: creature che rappresentano il suo unico legame con il mondo, il suo equilibrio emotivo e spirituale.
Microcosmo questo all’interno del quale Douglas trova una forma di armonia, un ordine alternativo fondato su affetto e fiducia, qualità che nel mondo esterno sono perdute. La sua figura si inserisce nel lungo percorso bessoniano dell’eroe solitario: fragile ma puro, che lotta per conservare un briciolo di umanità in un contesto degradato.
Come Léon o Nikita, Douglas incarna il tema dell’individuo contro il mondo in modo ancor più viscerale e spirituale: non combatte per sopravvivere, ma per amare ed essere amato, trasformando la violenza subita in tenerezza e protezione. I cani non sono semplici compagni, bensì metafore dell’umanità perduta, simboli di lealtà, compassione e innocenza, attraverso cui Besson costruisce una parabola sulla redenzione, in cui l’animalità diventa più umana dell’uomo stesso.
DogMan possiede inoltre un forte valore simbolico e religioso, poiché Douglas è una sorta di Cristo contemporaneo, circondato dai suoi “apostoli” a quattro zampe, pronto al sacrificio per salvare ciò che ama. Le inquadrature dall’alto, le luci dorate nei momenti di pace, i riferimenti alla croce e al perdono suggeriscono una spiritualità laica e profonda: non una fede in Dio, ma nella possibilità dell’amore come forza salvifica, che rende DogMan anche un moderno percorso sul dolore, sulla diversità e sulla necessità di credere nella bontà, anche quando tutto intorno sembra perduto.
Il corpo, la luce e il suono dell’anima
Gran parte della forza di DogMan deriva dall’interpretazione straordinaria di Caleb Landry Jones, attore texano di rara sensibilità, già acclamato in Three Billboards Outside Ebbing, Missouri e Nitram, con cui ha conquistato il premio come miglior attore al Festival di Cannes. In questo film, Jones offre una performance totale, in cui corpo, voce e sguardo diventano strumenti di una confessione viscerale. Il suo Douglas è un personaggio complesso, spezzato ma vitale, capace di incarnare contrasti profondi: fragilità e ferocia, dolcezza e rabbia, ironia e disperazione.
Imprigionato in una sedia a rotelle, Douglas vive in un corpo ferito ma animato da una forza interiore inarrestabile. Jones rende palpabile questo conflitto fisico e psicologico attraverso micro-espressioni, tremiti, sospiri: la voce roca, spesso spezzata, trasmette la sofferenza di chi è costretto a parlare da una posizione di debolezza, ma che non rinuncia alla propria dignità. La sua recitazione è quasi teatrale, ma mai artificiosa: ogni suo gesto, ogni sua parola sono calibrati per restituire la complessità di un uomo che, nonostante tutto, continua a credere nella possibilità dell’amore.
Le scene in cui Douglas si traveste da donna o si esibisce in numeri di cabaret non sono semplici eccentricità: rappresentano la sua rinascita artistica e identitaria. Il travestimento, la recitazione, la musica diventano per lui atti di liberazione, spazi in cui può essere finalmente se stesso. Quando canta La vie en rose di Edith Piaf, la voce incerta e dolente di Jones si trasforma in un grido d’amore universale, capace di riempire il buio che lo circonda.
Sul piano visivo, Luc Besson dirige con una maturità nuova, lontana dagli eccessi spettacolari di Valerian ma sempre riconoscibile per la cura formale e la potenza estetica. La fotografia di Colin Wandersman alterna luci fredde e ombre taglienti nei momenti di pericolo a tonalità calde e dorate nelle scene di intimità con i cani, creando un contrasto che riflette la lotta tra oscurità e redenzione.
Il montaggio, preciso e ritmico, alterna silenzi e scoppi improvvisi di violenza, mentre la colonna sonora di Éric Serra, fedele collaboratore di Besson, accompagna ogni emozione con sonorità elettroniche e orchestrali che si fondono in un respiro unico. Infine, la gestione dei cani è un elemento tecnico e simbolico straordinario: ciascuno di loro ha un ruolo, una personalità, una presenza narrativa che rende il film un vero coro di anime ferite, unite da un legame più forte di qualsiasi parola.
Curiosità sulla produzione
Dietro l’intensità di DogMan si nascondono scelte di produzione e dettagli che rendono il film ancora più affascinante. Caleb Landry Jones, ad esempio, ha trascorso settimane ad avvicinarsi e conoscere i cani sul set, sviluppando un legame così profondo da rendere autentiche le emozioni condivise sullo schermo; ogni animale ha una propria personalità, contribuendo alla costruzione di un vero coro di anime ferite. La città in cui si muove Douglas è stata ricreata in uno spazio industriale abbandonato, così da rappresentare il realismo, l’allegoria, e il suo mondo interiore.
Le scene in cui Douglas si traveste o si esibisce in numeri di cabaret sono state girate in sequenze lunghe, con musica dal vivo, permettendo a Jones di trasmettere con autenticità la liberazione e la rinascita del personaggio. Anche la colonna sonora, firmata da Éric Serra, mescola orchestrazioni tradizionali ed elettronica, accentuando la dualità tra oscurità e redenzione che pervade l’intero film. Infine, molti dettagli visivi contengono simbolismi sottili ma significativi: luci dorate, composizioni dall’alto e forme che ricordano croci o gesti di protezione trasformano ogni inquadratura in un piccolo enigma visivo, invitando lo spettatore a scoprire il messaggio nascosto dietro l’apparente semplicità della scena.
L’amore come ultima salvezza nell’oscurità
DogMan non si limita a raccontare la storia di Douglas: offre uno sguardo sulla condizione umana ai margini, invitando a riflettere sulle relazioni, sui legami di cura e sulla capacità di resistere anche in contesti estremamente ostili. La forza del film risiede nella costruzione di uno spazio narrativo e visivo che diventa simbolo di introspezione, dove ogni scelta estetica e narrativa contribuisce a far emergere tensioni interiori, etiche e morali.
In questo senso, l’opera di Besson si pone come un esercizio di osservazione attenta e meditativa: mostra come anche in un mondo segnato dalla violenza e dall’esclusione possano nascere piccoli atti di significato, di riconoscimento e di empatia. L’approfondimento della marginalità e della solitudine di Douglas diventa così uno strumento per esplorare la complessità delle emozioni, della resilienza e della ricerca di senso, aprendo una prospettiva sul mondo e sull’umanità che va oltre la semplice narrazione.
©Riproduzione Riservata
Emanuela Giuliani