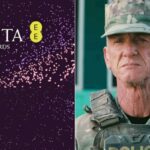Flashdance, alcune curiosità sul film diretto dal regista britannico Adrian Lyne che fece ballare una generazione.
Scritto da Thomas Hedley e Joe Eszterhas, e diretto dal regista britannico Adrian Lyne, Flashdance uscì nelle sale cinematografiche nel 1983, diventando rapidamente un fenomeno culturale mondiale. Il film contribuì a lanciare la carriera della giovane Jennifer Beals – allora appena ventenne e studentessa alla Yale University – catapultandola nel firmamento delle star di Hollywood. Ma Flashdance fu molto più di una semplice storia di riscatto: fu un mix accattivante di danza, musica pop, estetica da videoclip e spirito anni ’80, capace di imprimersi nell’immaginario collettivo e lasciare un’impronta duratura nel cinema e nella cultura popolare.
La trama ruota attorno ad Alex Owens, un personaggio inusuale per l’epoca poiché giovane donna indipendente, saldatrice di giorno in un’acciaieria di Pittsburgh e ballerina di notte in un locale notturno con il sogno di entrare in una prestigiosa accademia di danza, ma la strada per realizzarlo è disseminata di ostacoli, paure e pregiudizi. Con determinazione e passione, Alex lotta per affermare il proprio talento in un mondo che sembra non volerle riconoscere una possibilità.
Il film colpì per la sua estetica patinata, fatta di luci al neon, montaggi serrati e un uso innovativo della musica – elementi che ricordavano molto i videoclip musicali della neonata MTV, lanciata appena due anni prima, nel 1981. Questo stile visivo influenzò profondamente il cinema popolare degli anni ’80 e contribuì a consolidare la carriera del regista Adrian Lyne, che avrebbe poi diretto altri successi provocatori come 9 settimane e ½ (1986) e Attrazione fatale (1987).
Flashdance non fu solo un successo commerciale: fu un manifesto visivo ed emotivo di un’epoca. Rappresentò l’ideale di una giovane donna libera, determinata e indipendente, capace di inseguire i propri sogni nonostante gli ostacoli. Il film parlava di emancipazione e autodeterminazione in un’epoca in cui il ruolo delle donne stava cambiando anche nella cultura mainstream.
Ancora oggi, a distanza di oltre quarant’anni, Flashdance continua a ispirare coreografi, registi, stilisti e appassionati di danza. La sua colonna sonora è ancora trasmessa, le sue scene più iconiche vengono omaggiate nei videoclip e negli spot pubblicitari, e il suo spirito di rivalsa continua a far sognare nuove generazioni.

Jennifer Beals non ballava in tutte le scene
Nonostante la sua presenza magnetica e il suo carisma, Jennifer Beals non era una ballerina professionista, e molte delle sequenze di danza più tecniche furono eseguite da una controfigura: la ballerina francese Marine Jahan. In alcune scene, per realizzare salti acrobatici particolarmente complessi, fu persino utilizzato un ballerino uomo, Crazy Legs (Richard Colón), esperto di breakdance, travestito da donna. La produzione cercò di mantenere il segreto su questi dettagli, oscurando i volti con giochi di luce e montaggio serrato. Tuttavia, quando la verità venne a galla, scoppiò una polemica: molti spettatori, convinti di assistere alle autentiche performance della Beals, si sentirono ingannati. Questa vicenda aprì un dibattito sull’uso delle controfigure nel cinema e sull’attribuzione del merito artistico.
Una colonna sonora da record
Uno degli elementi più distintivi di Flashdance fu senza dubbio la sua colonna sonora, che diventò un vero fenomeno culturale. Il brano principale, Flashdance…What a Feeling, cantato da Irene Cara, vinse l’Oscar per la Miglior Canzone Originale nel 1984 e fu scritto da Cara insieme al celebre compositore Giorgio Moroder e Keith Forsey, e la sua combinazione di synth-pop e carica emotiva incarnava perfettamente lo spirito degli anni ’80, anche Maniac, di Michael Sembello, nata inizialmente come canzone horror-parodica, fu riadattata per il film e divenne un altro singolo di enorme successo. L’album della colonna sonora vendette oltre sei milioni di copie negli Stati Uniti, restando per settimane in cima alle classifiche di Billboard, e contribuì a definire il ruolo fondamentale della musica nei film commerciali.
Un film a basso budget diventato cult
Realizzato con un budget modesto di circa 7 milioni di dollari, Flashdance fu un caso eclatante di successo commerciale: incassò oltre 200 milioni di dollari a livello globale. Diretto da Adrian Lyne, allora conosciuto soprattutto per spot pubblicitari, il film fu inizialmente accolto con freddezza dalla critica, che lo accusò di privilegiare lo stile sulla sostanza. Tuttavia, il pubblico ne decretò il trionfo: le scene di danza, la fotografia patinata e il montaggio frenetico piacquero soprattutto ai giovani. Il successo di Flashdance consolidò un nuovo formato narrativo, il cosiddetto “film videoclip”, dove la musica e l’estetica prevalevano su una trama lineare, influenzando opere successive come Footloose e Dirty Dancing.
Moda e costume: l’icona della felpa oversize
Il look di Alex Owens – felpa grigia con la spalla scoperta, collant, scaldamuscoli e scarpe da ballo – divenne un’icona visiva degli anni ’80, questo stile casual e seducente, apparentemente studiato a tavolino, nacque in realtà da un’improvvisazione: Jennifer Beals, dopo aver ristretto accidentalmente una felpa in lavatrice, tagliò il colletto per poterla indossare e i costumisti trovarono la scelta così interessante da farla diventare parte integrante del personaggio. Il look si diffuse rapidamente nella cultura popolare, influenzando la moda dell’epoca, con milioni di ragazze che copiarono lo stile di Alex, trasformandolo in simbolo di ribellione e indipendenza femminile.
Una storia ispirata alla realtà
Alla base di Flashdance c’è la storia vera di Maureen Marder, una donna di Toronto che lavorava come saldatrice di giorno e ballerina di notte in un locale chiamato “The Foxes Den”, la Paramount acquistò i diritti della sua storia per soli 2.300 dollari, senza prevedere alcun diritto sulle future royalties. Quando il film divenne un fenomeno mondiale, la Marder cercò di ottenere un risarcimento maggiore, ma non riuscì nel suo intento e il suo caso alimentò un acceso dibattito sull’equità dei contratti nel mondo dell’intrattenimento, in particolare per le persone comuni la cui vita viene adattata per il grande schermo. Ancora oggi è citato come esempio di come Hollywood possa trarre enormi profitti da storie reali, lasciando i protagonisti originali senza un riconoscimento economico adeguato.
©Riproduzione Riservata
Emanuela Giuliani