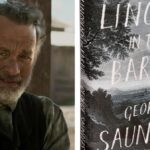Hedda di Nia DaCosta esplora l’identità femminile con eleganza e distacco, tra simbolismi e tensioni emotive in una rilettura moderna.
Dopo essersi cimentata con l’horror di Candyman e aver affrontato il cinecomic con The Marvels, Nia DaCosta torna a un cinema più intimo e personale con Hedda Gabler, una libera rivisitazione del celebre dramma in quattro atti di Henrik Ibsen. Il film, presentato in anteprima al Toronto International Film Festival e ora in concorso alla 20ª edizione della Festa del Cinema di Roma, è un’opera visivamente elegante e concettualmente ambiziosa, ma la sua sofisticata freddezza formale rischia di limitare la piena riuscita emotiva del racconto.
Tra modernità e prigione interiore
Ambientato nell’Inghilterra degli anni ’50, il film è avvolto da un’estetica rétro e sospesa, lontana dalle urgenze del presente ma densa di simbolismi. I luoghi in cui si muove la protagonista restituiscono con efficacia la sensazione di isolamento e stasi emotiva che la pervade, accentuando l’atmosfera rarefatta e oppressiva che caratterizza l’intero film.
Nel testo originale di Ibsen, Hedda Gabler è una donna prigioniera del proprio ruolo sociale: intrappolata in un matrimonio borghese, incapace di adattarsi ai codici imposti dalla società, consapevole della propria intelligenza ma priva degli strumenti per usarla in modo costruttivo. Consunta dall’odio e dalla gelosia, manipola gli altri fino a spingere l’amico di un tempo, Ejlert Løvborg, al suicidio. È una figura tragica non perché subisce passivamente, ma perché partecipa attivamente alla propria rovina. Vive un conflitto insanabile tra il desiderio di libertà e la paralisi dell’azione.
Nel film, la DaCosta rilegge il personaggio con una sensibilità più contemporanea. La sua Hedda è una sorta di regina della mondanità, che organizza sontuosi party in stile Grande Gatsby e si ritrova destabilizzata quando, dal passato, riemerge un grande amore — una donna. Questa versione del personaggio è più consapevole, moderna nella psicologia, ma non per questo meno tragica. Colta e lucida, osserva il mondo con distacco analitico, ma resta incapace di trasformare davvero il proprio destino, in un’epoca in cui i ruoli di genere si trovano in bilico tra tradizione e modernità.
Un senso di transizione all’interno del quale Hedda non è solo una moglie infelice, ma una rappresentazione della crisi d’identità femminile, in lotta continua tra le aspettative esterne e i desideri repressi. Una protagonista, quindi, forte ma emotivamente distante che, nonostante la prova convincente di una spesso magnetica Thessa Thompson, è una donna che non esplode mai davvero, ma si consuma lentamente. I suoi silenzi, i suoi sguardi, le mezze frasi cariche di significato raccontano più di quanto dicano i dialoghi, ma la fin troppo misurata performance si traduce in un’emotività trattenuta che rende difficile l’immedesimazione dello spettatore.
Un’identificazione resa ancor più difficile anche perché il film non cerca mai il coinvolgimento diretto, preferendo stimolare la riflessione, offrendo spunti e suggerendo significati più che comunicarli. Il film, infatti, chiede molto a chi guarda, giocando sull’accumulo di tensione interiore e non sull’esplosione drammatica: dalle inquadrature simmetriche, ai movimenti lenti, alla fotografia desaturata e alle luci naturali che sottolineano il senso di sospensione. Ma questa scelta, se da un lato è coerente con il senso dell’opera, dall’altro comporta il rischio, per l’appunto, di alienare lo spettatore.
Le relazioni: un terreno poco sviluppato
Uno degli aspetti meno riusciti del film è la gestione dei personaggi secondari. Se nella pièce di Ibsen, infatti, ogni figura ha un ruolo chiave nell’alimentare il conflitto interiore di Hedda — dal marito Tesman, uomo mediocre e insicuro, all’instabile Ejlert Løvborg, fino alla determinata Thea — qui molte relazioni restano in superficie.
La dinamica tra Hedda e Løvborg, ad esempio — qui donna e vecchio grande amore di Hedda — manca di ambiguità, e lei, presentata come un’intellettuale autodistruttiva, non viene approfondita a sufficienza per rendere credibile il legame e la rivalità con Hedda. Allo stesso modo, il rapporto con Thea, che in Ibsen rappresenta un modello alternativo di femminilità e che qui assume il ruolo di nuovo amore di Løvborg, non riesce a generare il necessario contrasto. Una narrazione, quindi, fortemente centrata su Hedda, che penalizza una coralità che avrebbe potuto arricchire il film e renderlo più dinamico, intrigante, accattivante e profondo.
Come nell’opera di Ibsen, inoltre, anche nel film la casa non è semplicemente uno spazio domestico, ma il simbolo di una prigione mentale e sociale, specchio dell’anima di Hedda, che finge controllo ma è attraversata da un’inquietudine viscerale e ingestibile. In questo spazio chiuso si consuma una tragedia moderna: non quella del delitto o della vendetta, ma della rinuncia, dell’impotenza, della rabbia repressa che finisce per implodere — e che viene restituita con maggiore efficacia.
Una visione elegante ma non del tutto riuscita
Con Hedda, Nia DaCosta firma un’opera visivamente curata e coraggiosa nella sua volontà di rileggere un classico senza banalizzarlo, affrontando temi attualissimi — l’identità femminile, la pressione sociale, il senso di inadeguatezza — attraverso un linguaggio asciutto e simbolico, più intellettuale che emotivo.
Tuttavia, la scelta di un’estetica così controllata e di un ritmo narrativo lento rende il film meno accessibile, incapace di toccare davvero lo spettatore. Un film ambizioso, intelligente, elegante, ma non del tutto riuscito, consapevole che, con un maggiore equilibrio tra forma e sostanza, il risultato avrebbe potuto essere più potente e coinvolgente.
©Riproduzione Riservata
Emanuela Giuliani
Il Voto della Redazione: