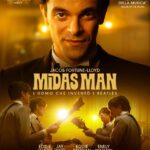Dal 5 marzo su Netflix la serie evento de: Il Gattopardo, adattamento del celebre romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa.
Pubblicato postumo da Feltrinelli nel 1958, a un anno dalla morte del suo autore Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo è considerato uno dei capolavori assoluti della letteratura italiana e internazionale. Vincitore del Premio Strega nel 1959, il romanzo ha segnato una svolta nel modo di raccontare la storia nazionale, offrendo uno sguardo disincantato e al tempo stesso struggente sulla decadenza dell’aristocrazia siciliana durante l’unificazione d’Italia.
Ispirato alle vicende della famiglia dell’autore, Il Gattopardo narra un momento cruciale del Risorgimento: dopo lo sbarco a Marsala di Garibaldi e dei suoi Mille, la Sicilia si trova a dover affrontare il passaggio dal Regno delle Due Sicilie al neonato Regno d’Italia. Un passaggio che Tomasi di Lampedusa racconta attraverso gli occhi di Don Fabrizio Corbera, Principe di Salina, trasposizione letteraria del suo bisnonno, il principe Giulio Fabrizio Tomasi, figura emblematica di un mondo che sta per scomparire, attorno a cui ruotano personaggi chiave come il giovane e ambizioso Tancredi, l’affascinante Angelica e l’intensa Concetta.
Tra i romanzi più venduti del secondo dopoguerra, Il Gattopardo è stato portato sul grande schermo nel 1963 da Luchino Visconti, in un film divenuto iconico, vincitore della Palma d’Oro al Festival di Cannes. Ora, sessant’anni dopo, è Netflix a raccogliere la sfida: dal 5 marzo è disponibile una nuova e ambiziosa serie in sei episodi, con l’obiettivo di rileggere in chiave contemporanea l’opera di Tomasi di Lampedusa.
Il Gattopardo, non sempre vogliamo che tutto rimanga come è

Diretta da Tom Shankland, con la partecipazione di Giuseppe Capotondi (episodio 4) e Laura Luchetti (episodio 5), e scritta da Richard Warlow — anche ideatore e produttore esecutivo insieme a Benji Walters — la nuova serie Netflix non si propone come un semplice remake del capolavoro cinematografico di Luchino Visconti. Al contrario, ambisce a restituire nuova vita al romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, rimanendo fedele alla sua essenza ma discostandosi volutamente dalla maestosa e malinconica visione degli anni Sessanta.
Il cast annovera Kim Rossi Stuart nei panni del Principe di Salina, Benedetta Porcaroli in quelli di Concetta, Deva Cassel nel ruolo di Angelica e Saul Nanni in quello di Tancredi, accanto a loro, un ensemble di attori italiani di talento: Paolo Calabresi, Francesco Colella, Astrid Meloni e Greta Esposito. L’ambientazione, immersa in una Sicilia ottocentesca decadente e affascinante, è resa con grande accuratezza dai costumi firmati da Carlo Poggioli ed Edoardo Russo, dalle scenografie curate da Dimitri Capuani e dalle musiche originali composte da Paolo Buonvino, che amplificano il tono evocativo della narrazione.
Ciò nonostante, l’ambizione della serie non si traduce in una riuscita pienamente convincente con i primi tre episodi privi di una vera tensione emotiva, trattenuti da una narrazione che stenta a decollare, quasi timorosa di tradire la sacralità dell’originale, e nei successivi in cui si avverte un crescendo narrativo più coinvolgente, fatto di intrighi, seduzione e improvvisi slanci di passione. La costruzione psicologica dei personaggi appare a tratti superficiale, e le interpretazioni non sempre riescono a colpire nel segno.
Kim Rossi Stuart possiede l’eleganza necessaria per incarnare Don Fabrizio, ma non riesce a restituirne la forza carismatica e il tormento interiore che lo rendono uno dei personaggi più memorabili della letteratura italiana, il suo accento siciliano, poco credibile, compromette ulteriormente il processo di immedesimazione. Anche Saul Nanni, nei panni di Tancredi, fatica a trasmettere l’ambigua vitalità e l’opportunismo scintillante che definivano il personaggio originario, così come Deva Cassel, che pur dotata di fascino e presenza scenica, non restituisce appieno la complessità emotiva e la passione prorompente che Angelica incarna nel romanzo.
La vera rivelazione della serie invece è Benedetta Porcaroli nel ruolo di Concetta, la quale tradizionalmente relegata a figura di secondo piano, nella serie invece assume un ruolo sorprendentemente centrale. Educata secondo i rigidi precetti dell’aristocrazia e della religione, Concetta attraversa un processo di trasformazione silenziosa ma profonda, fino a diventare il simbolo stesso del cambiamento. Il suo è un cammino di emancipazione interiore, che la conduce a una nuova consapevolezza di sé, dei propri desideri e del proprio posto nel mondo. Una ribellione composta ma determinata, capace di sfidare il patriarcato con fermezza e grazia.
Ed è proprio in questa rilettura che la celebre frase del romanzo: “Se vogliamo che tutto rimanga com’è, bisogna che tutto cambi”, acquista una nuova profondità. Se nell’opera originale di fatto rappresentava l’astuta strategia dell’aristocrazia per sopravvivere al cambiamento apparente, nella serie questa citazione riecheggia nei conflitti interiori dei personaggi. La trasformazione, suggerisce la narrazione, non è solo politica o sociale: può essere personale, silenziosa, radicale. Una rivoluzione dell’anima, che scardina certezze e ruoli prestabiliti senza bisogno di clamore.
Introspezione questa che, se fosse stata sviluppata con maggiore coerenza in tutti i personaggi, avrebbe potuto rendere la serie un’opera di assoluto rilievo, che resta invece un opera affascinante ma disomogenea, che brilla a tratti grazie alla potenza visiva e alla forza evocativa delle sue ambientazioni, ma che spesso lascia lo spettatore con il desiderio di un coinvolgimento più profondo.
Tuttavia non si può non riconoscere il merito a Netflix di aver offerto una nuova chiave di lettura a un romanzo che, a quasi settant’anni dalla pubblicazione, continua a parlare al presente. Un racconto sul potere, sull’identità e sul prezzo del progresso, che oggi come allora chiede di essere ascoltato, che suonando come una profezia, invita ancora una volta a guardarsi dentro.
“Queste donne appassite. Questi uomini stupidi. Sono solo prede indifese condannate a godere del piccolo raggio di luce concesso loro. Tra la culla e la morte. Noi fummo i gattopardi, i leoni. Chi ci sostituirà saranno gli sciacalletti, le iene…”
©Riproduzione Riservata
Emanuela Giuliani
Il Voto della Redazione: