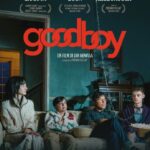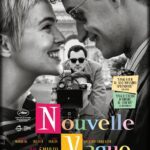Il racconto dei racconti di Garrone: fiabe dimenticate trasformate in cinema poetico, grottesco e simbolico, tra meraviglia e oscurità.
Il racconto dei racconti di Matteo Garrone nasce come un ambizioso esperimento di trasposizione cinematografica delle fiabe tratte dalla raccolta Lo cunto de li cunti di Giambattista Basile, un’opera cardine del Seicento napoletano, caratterizzata da un linguaggio ricco, barocco e a tratti crudamente realistico. Una decisione questa Garrone di distaccarsi dalle fiabe canoniche, come quelle dei fratelli Grimm o di Charles Perrault, per concentrarsi su storie marginali, spesso dimenticate, che riflette la volontà di riportare in vita patrimoni culturali meno noti, ma densi di immaginario e di tensione emotiva, attraverso il linguaggio cinematografico.
Il regista infatti, non si limita a trasferire fedelmente i racconti dalla pagina allo schermo, ma li rielabora in chiave visiva, trasformando la parola in immagine e suono, amplificando la loro potenza poetica e simbolica. In questo modo, il cinema diventa uno strumento capace di evocare emozioni primordiali, paure ancestrali e riflessioni universali, mostrando come il meraviglioso possa convivere con l’oscuro, il grottesco e il perturbante. Garrone costruisce così un universo narrativo adulto, dove le fiabe non sono semplici racconti moralistici o consolatori, bensì mezzi per esplorare i desideri e le fragilità umane.
La struttura narrativa e la tripartizione fiabesca
Il film si articola in tre episodi autonomi, legati da un filo tematico comune che attraversa tutte le storie: la tensione tra desiderio, potere e trasformazione.
Nel primo episodio, la vicenda della regina ossessionata dalla maternità mostra la frenesia del desiderio umano e le conseguenze che esso può generare. La regina compie azioni sovrannaturali e rituali inquietanti per ottenere un figlio, e Garrone intreccia il meraviglioso e il grottesco in scene che oscillano tra fascinazione e disgusto. La sua fissazione, tradotta visivamente in creature mostruose e in immagini disturbanti, diventa metafora della brama umana che supera i confini naturali, trasformando la narrativa fiabesca in tragedia morale e psicologica.
Il secondo episodio, dedicato alla principessa Salma e alla creatura mostruosa, esplora la paura del diverso e l’attrazione per l’ignoto. La creatura, deformata e minacciosa, rappresenta l’ambivalenza dei desideri umani, il fascino del proibito e l’ambizione che spinge a confrontarsi con ciò che spaventa.
Nel terzo episodio, che racconta le vicende del re e della sua brama di eternità, Garrone mette in scena la vanità e la crudeltà del potere. Il sovrano accecato dall’immortalità diventa simbolo della fragilità umana, mentre le immagini mescolano sublime e grottesco, generando contrasti che evidenziano la tensione tra aspirazione e limite.
L’alternanza di stili visivi e tonalità emotive tra i tre episodi permette al regista di sperimentare forme narrative differenti, pur mantenendo una coerenza poetica e tematica che unifica l’intera opera.
L’estetica visiva: meraviglia e orrore
L’estetica di Il racconto dei racconti è il fulcro dell’universo narrativo costruito da Garrone, in cui la componente visiva non è semplice corredo della storia, ma vera e propria materia narrativa. I paesaggi del film oscillano costantemente tra realismo e fantastico, fondendo scenari naturali dettagliati e concreti con elementi che sembrano usciti da un quadro barocco o manierista. Questa scelta non è solo estetica: crea uno stato di sospensione percettiva nello spettatore, in cui ciò che è familiare e reale si intreccia con ciò che appartiene al sogno e all’incubo, generando un effetto di meraviglia e inquietudine simultanee. Le scenografie, spesso monumentali ma tangibili, e le architetture barocche ricordano la teatralità delle fiabe antiche, sottolineando l’artificialità e la simbolicità del mondo narrativo, pur rendendolo concretamente percepibile.
I costumi e il trucco giocano un ruolo fondamentale nella caratterizzazione dei personaggi. Ogni dettaglio, dalle corone e dagli abiti regali fino ai segni fisici di deformità o di trasformazione, è studiato per amplificare l’effetto grottesco e fiabesco insieme. La fisicità dei personaggi è accentuata dal trucco e dalla recitazione corporea, rendendo tangibile la distanza tra ciò che è umano e ciò che è simbolico, tra desiderio e ossessione. Garrone predilige creature e oggetti reali, evitando il digitale eccessivo, e ciò conferisce una materialità palpabile al mondo fantastico: il sangue, le mani mostruose, le interiora, le texture dei corpi deformi e degli animali diventano strumenti narrativi che parlano al corpo dello spettatore prima ancora che alla sua mente.
L’uso del suono e della musica completa la dimensione estetica: i rumori ambientali, la colonna sonora di Alexandre Desplat e l’alternanza tra silenzio e musica contribuiscono a creare tensione, meraviglia e disagio emotivo. Il silenzio, in particolare, funziona come strumento drammaturgico: le pause amplificano la percezione del grottesco, permettendo allo spettatore di interiorizzare il senso di straniamento. In questo modo, bellezza e orrore convivono senza soluzione di continuità, trasformando il film in un’esperienza multisensoriale in cui l’emozione estetica e quella morale si intrecciano profondamente.
Il meraviglioso in chiave adulta
A differenza delle fiabe tradizionali rivolte ai bambini, Il racconto dei racconti affronta tematiche complesse, dolorose e spesso ambigue, rendendo il meraviglioso una lente per indagare la natura umana. I desideri fondamentali – la ricerca di un figlio, il potere assoluto o l’illusione di immortalità – diventano fonti di conflitto, rivelando la fragilità e le ossessioni dei personaggi. Garrone non edulcora la violenza, la morte o la deformità: queste non sono gratuità visive, ma strumenti simbolici che rendono concreti i dilemmi morali, le passioni e le paure più profonde.
La narrazione esplora costantemente la tensione tra reale e fantastico, mostrando come l’incanto possa celare il pericolo e come il meraviglioso contenga sempre una dimensione oscura. Ad esempio, la creatura che emerge dal racconto della principessa Salma è al tempo stesso mostruosa e affascinante, incarnando il fascino ambiguo del diverso e del proibito, costringendo lo spettatore a confrontarsi con desideri e paure universali. In questa prospettiva, la fiaba cinematografica diventa strumento di riflessione sulle ossessioni umane, sulle contraddizioni interiori e sulle tensioni esistenziali: non si limita a divertire o insegnare, ma interroga e provoca, stimolando una risposta emotiva e intellettuale profonda.
La forza simbolica e universale delle fiabe cinematografiche
Il cinema di Garrone permette di rendere visibile ciò che nella parola scritta rimane spesso all’immaginazione: mostri, metamorfosi, ambientazioni e corpi diventano simboli tangibili dei desideri, delle paure e delle fragilità umane. La forza di queste immagini risiede nella loro capacità di parlare simultaneamente al livello narrativo, estetico e simbolico: un corpo deformato, una trasformazione sovrannaturale o un paesaggio inquietante non sono solo elementi fantastici, ma metafore dei limiti, delle ambizioni e delle ossessioni umane.
Nonostante il contesto antico e fiabesco, le storie di Garrone dialogano con il presente, affrontando conflitti ed emozioni universali: il desiderio di maternità, l’ansia di immortalità, la brama di potere e la paura del diverso sono temi eterni, riletti con profondità psicologica e complessità simbolica. La mescolanza di poesia, grottesco e realismo crudo conferisce alle fiabe una rielaborazione originale, in cui il linguaggio cinematografico non si limita a illustrare, ma amplifica e trasforma la tradizione letteraria, creando un’esperienza intensa, multisensoriale e universale.
A tal proposito, Il racconto dei racconti non solo restituisce alla luce un patrimonio culturale dimenticato, ma lo rinnova e lo rende accessibile, dimostrando che le fiabe, anche quelle meno conosciute, possono continuare a parlare con forza agli spettatori contemporanei, rivelando la profondità e l’attualità di desideri, paure e tensioni universali.
Fiaba e cinema, un connubio creativo
Il racconto dei racconti dimostra come il cinema possa trasformare la fiaba in un terreno di sperimentazione narrativa e visiva, in cui meraviglia, orrore e poesia si fondono in un unico flusso creativo. Garrone sfrutta la forza simbolica e sensoriale delle immagini per rendere universali storie antiche, rivelando quanto anche le fiabe meno conosciute possano diventare strumenti straordinari per esplorare desideri, contraddizioni e emozioni umane. La trasposizione cinematografica non si limita a illustrare il testo letterario, ma lo rinnova e lo amplifica, dimostrando la vitalità di una tradizione che continua a parlare al presente e a riflettere sulla condizione umana con originalità e profondità.
©Riproduzione Riservata
Emanuela Giuliani