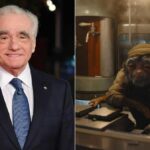Nitram esplora isolamento e fragilità mentale, ricostruendo la vita di Martin Bryant prima della strage di Port Arthur.
Diretto da Justin Kurzel, noto per il suo stile crudo e immersivo, Nitram (2021) prende il titolo dal nome invertito di “Martin”, in riferimento a Martin Bryant, autore della strage di Port Arthur in Australia nel 1996. Non si tratta di un documentario, ma di una ricostruzione narrativa ispirata a fatti reali, che segue la vita del protagonista prima della tragedia, esplorando le sue frustrazioni, il disagio sociale e i segnali di sofferenza mentale. La strage di Port Arthur, avvenuta in Tasmania, causò la morte di 35 persone e il ferimento di altre 23, diventando uno degli episodi di violenza armata più drammatici nella storia australiana e scatenando un profondo dibattito sul controllo delle armi e sul riconoscimento precoce dei segnali di disagio psicologico.
Il film si concentra su Nitram, un giovane uomo che cresce in un contesto familiare problematico e in una società che fatica a comprenderlo, mettendo in luce i suoi rapporti interpersonali, la solitudine, le ossessioni e i segnali di instabilità psicologica che lentamente sfociano in gesti estremi. La regia di Kurzel amplifica l’isolamento emotivo del protagonista attraverso un uso sapiente di luce, suono e silenzi, immergendo lo spettatore nella sua inquietudine e nella tensione che cresce pagina dopo pagina.
Isolamento, fragilità e la spirale della violenza
Nitram esplora in profondità l’alienazione e l’isolamento del protagonista, ritratto come un individuo emarginato, incapace di stabilire relazioni sane con il mondo circostante. Ispirato alla figura reale di Martin Bryant, Nitram è una persona segnata da fragilità emotive e psicologiche, le cui difficoltà nell’interazione sociale, unite a una crescente frustrazione interiore, evolvono lentamente verso comportamenti estremi. La narrazione mette in luce come l’isolamento sociale e la mancanza di supporto emotivo possano contribuire alla radicalizzazione personale, offrendo una riflessione sulla vulnerabilità dell’individuo di fronte all’emarginazione.
Parallelamente, il film approfondisce le fratture psicologiche del protagonista, mostrando la sua incapacità di gestire rabbia, ansia e frustrazione, tensioni che si accumulano fino a esplodere. La rappresentazione del disagio mentale è intensa e realistica, priva di sensazionalismi: l’obiettivo non è demonizzare il personaggio, ma mostrarne la complessità interiore, le ambivalenze e i tormenti che lo consumano. Lo spettatore può così comprendere, senza giustificare, la graduale trasformazione emotiva e psicologica che precede gli atti violenti.
La ferocia, elemento centrale della storia, non viene mai mostrata come fine a se stessa, ma riflette una società che spesso ignora segnali premonitori e segnali di disagio, dalla difficoltà a costruire legami sociali fino all’inadeguatezza dei sistemi di supporto psicologico e familiare. Questo solleva interrogativi sul ruolo delle istituzioni, della comunità e della famiglia nella prevenzione delle tragedie, con le dinamiche familiari che assumono un peso determinante. Conflitti, incomunicabilità e relazioni tese con le figure di riferimento contribuiscono a creare un terreno instabile, nel quale Nitram/Bryant si muove con crescente difficoltà. L’ambiente personale e sociale diventa così chiave per comprendere non solo il percorso del personaggio, ma anche le condizioni che possono favorire lo sviluppo di tali comportamenti.
Infine, il film intreccia la narrazione personale di Nitram con una riflessione attenta sul contesto storico e sociale australiano dell’epoca. Pur trasfigurata per esigenze narrative, la ricostruzione dei fatti reali consente di osservare la strage di Port Arthur non solo come un episodio di cronaca, ma come sintomo di difficoltà collettive, carenze sistemiche e fragilità psicologiche individuali, creando un ponte tra storia reale e introspezione cinematografica.
Caleb Landry Jones: il volto inquietante dell’alienazione
Cuore pulsante del film è Caleb Landry Jones, che offre una performance intensa e disturbante, capace di catturare ogni sfumatura del personaggio e di rendere visibile il graduale deterioramento emotivo e mentale di Nitram. Passando da momenti di apparente normalità a esplosioni di rabbia e frustrazione, Jones mantiene lo spettatore costantemente sospeso. Il suo linguaggio corporeo, i micro-sguardi e le tensioni sottili del corpo costruiscono un senso di disagio interiore palpabile, credibile e inquietante. Nonostante la natura violenta del protagonista, Jones infonde una forma di empatia disturbante che spinge a confrontarsi con la mente umana senza mai giustificare le azioni. La sua interpretazione trasforma il film in un’esperienza immersiva, in cui la tensione psicologica e le tematiche di alienazione e vulnerabilità mentale si percepiscono in ogni inquadratura.
Curiosità sulla produzione e sul set
La produzione di Nitram si distingue per un’attenzione estrema alla resa psicologica e visiva della storia. Per questo, il regista Justin Kurzel ha scelto di girare gran parte del film in ambientazioni reali dell’Australia meridionale, evitando di ricreare direttamente Port Arthur per rispettare la memoria delle vittime e il dolore delle famiglie. Le location sono state selezionate per evocare isolamento e claustrofobia, trasmettendo la solitudine e l’alienazione del protagonista. Il set era spesso immerso in un’atmosfera silenziosa e intensa, permettendo a Caleb Landry Jones di concentrarsi completamente sulla costruzione psicologica del personaggio; la troupe ha raccontato come l’attore fosse talmente immerso nel ruolo da rendere ogni scena straordinariamente autentica.
Un aspetto particolarmente efficace è l’uso calibrato di luce e suono: Kurzel ha prediletto tonalità fredde e naturali, accompagnate da un sound design minimale che valorizza silenzi e rumori ambientali. Questa scelta riflette lo stato d’animo di Nitram, amplifica l’immersione dello spettatore e sottolinea il disagio del protagonista senza ricorrere a effetti vistosi o artificiosi. La sceneggiatura ha richiesto approfondite fasi di ricerca sulle dinamiche psicologiche e sociali che hanno caratterizzato il Martin Bryant reale, con l’obiettivo di rappresentare la storia in maniera intensa ma rispettosa, evitando sensazionalismi e banalizzazioni.
La collaborazione tra regista, sceneggiatori e attori è stata particolarmente stretta: molte scene sono nate da improvvisazioni controllate e da approfondite discussioni su come rendere credibile ogni emozione. Questo approccio ha reso Nitram un film estremamente calibrato, in cui ogni dettaglio di scenografia, recitazione e regia contribuisce a creare un’esperienza intensa, malinconica e profondamente riflessiva, capace di trasmettere sia la tragedia personale del protagonista sia le implicazioni più ampie della vicenda reale.
Quando l’isolamento parla alla società
Nitram si impone come un’opera capace di provocare riflessione più che offrire risposte semplici. Al di là del ritratto del protagonista, il film solleva interrogativi sul ruolo della collettività e su come la società percepisce e gestisce le fragilità individuali. La forza di Kurzel sta nel costruire un’esperienza emotiva intensa e stratificata, dove ogni scelta visiva, sonora e narrativa contribuisce a generare un senso di inquietudine e introspezione.
Pur ispirandosi a eventi reali, il film si trasforma in una riflessione universale sulla vulnerabilità umana e sulle conseguenze di incomprensioni e trascuratezze sociali. Mostra come piccoli segnali trascurati possano accumularsi fino a produrre esiti devastanti, invitando lo spettatore a considerare la responsabilità individuale e collettiva nelle dinamiche sociali. Nitram lascia una scia di riflessione silenziosa ma potente, sottolineando la complessità della mente umana e la delicatezza dei confini tra normalità e deviazione.
©Riproduzione Riservata
Emanuela Giuliani