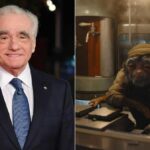Moda e cinema si influenzano a vicenda, dai celebri abiti di Audrey Hepburn ai look che hanno segnato la storia del cinema.
Fin dai primi giorni di Hollywood, moda e cinema hanno camminato fianco a fianco, intrecciando un legame profondo e reciproco. Il grande schermo, infatti, non è mai stato soltanto intrattenimento, ma anche una vetrina privilegiata per la moda, dove abiti, accessori e acconciature completano la narrazione, diventando strumenti di fascino, seduzione e comunicazione per il pubblico. Essi suggeriscono potere, innocenza, ribellione e raffinatezza, contribuendo a costruire l’identità dei personaggi. Allo stesso tempo, la moda trae spunto dal cinema, reinterpretando costantemente figure, atmosfere e stili in chiave contemporanea, dando vita a un legame profondo tra passerella e pellicola.
Negli anni ’30 e ’40, quando le star erano considerate vere divinità dello schermo, i costumi giocavano un ruolo fondamentale nel delineare il loro mito. Gli abiti scintillanti di Jean Harlow, i cappelli eleganti di Greta Garbo o i completi su misura di Cary Grant, oltre a rappresentare la moda, incarnavano un ideale di raffinatezza che gli spettatori desideravano imitare. Con l’arrivo del colore, negli anni ’50, i guardaroba cinematografici divennero ancora più spettacolari: tonalità vivide, tessuti preziosi e silhouette perfette trasformavano ogni abito in un vero manifesto culturale, facendo del cinema una fonte inesauribile di ispirazione per la moda quotidiana e i sogni di intere generazioni.
Quando un abito diventa leggenda
Alcuni film hanno lasciato un segno indelebile non solo per la trama, ma anche per gli abiti che li hanno resi immortali. In Colazione da Tiffany (1961), il celebre tubino nero indossato da Audrey Hepburn e firmato Hubert de Givenchy è diventato un’icona di stile senza tempo. La sua linea essenziale, impreziosita da un filo di perle e da grandi occhiali scuri, incarnava una nuova idea di femminilità: sofisticata, moderna e sorprendentemente accessibile. Da quel momento, il little black dress si è consacrato come simbolo eterno di eleganza e versatilità, entrando nella storia della moda.
Qualche anno prima, Marilyn Monroe aveva già reso immortale l’abito bianco a pieghe di Quando la moglie è in vacanza (1955). La celebre scena in cui il vento della metropolitana solleva la gonna è diventata un’immagine iconica del cinema mondiale, racchiudendo tutta la sensualità giocosa e lo spirito libertino degli anni Cinquanta. In quel momento, l’abito non solo consacrava Marilyn come icona di sex appeal, ma rifletteva — meglio di mille parole — i sogni, le libertà e le contraddizioni di un’intera epoca.
E dopo i classici anni del bianco e nero e le icone femminili degli anni Cinquanta, il rapporto tra moda e cinema si rinnova, adattandosi ai nuovi linguaggi degli anni successivi.
Negli anni Settanta, cinema e moda cambiano registro: in Io e Annie (1977), Diane Keaton sfida le convenzioni con giacche maschili, cravatte e pantaloni ampi, firmati Ralph Lauren. Il suo stile rompe gli schemi della femminilità tradizionale, introducendo un’eleganza androgina e indipendente che ispira generazioni di donne.
Negli anni Ottanta, la ribellione diventa visibile e scintillante: in Cercasi Susan disperatamente (1985), Madonna sfoggia corsetti, pizzi e gioielli vistosi, trasformando il film in un manifesto di controcultura urbana. Contemporaneamente, La febbre del sabato sera e Pretty Woman definiscono due icone opposte di stile: il completo bianco di John Travolta, simbolo dell’era disco, e l’abito rosso di Julia Roberts, emblema di trasformazione e ascesa sociale. La moda diventa narrazione e aspirazione.
Negli anni Novanta, lo stile cinematografico diventa linguaggio: il trench nero di Keanu Reeves in Matrix (1999) introduce un’estetica futuristica e minimalista, mentre Sex and the City trasforma gli abiti in strumenti di identità, desiderio e libertà attraverso Carrie Bradshaw.
Nel cinema, dunque, la moda è un linguaggio silenzioso che parla di emozioni, potere e trasformazioni interiori, rivelando chi è un personaggio, cosa desidera e come evolve nel corso della storia.
In Il diavolo veste Prada (2006), il guardaroba di Miranda Priestly e Andy Sachs va oltre l’apparenza del lusso: ogni outfit diventa una dichiarazione di forza, ambizione e rinascita personale. Quando Andy sostituisce i suoi maglioni anonimi con capi firmati Chanel e Valentino, non si limita a cambiare look — riscrive la propria identità, passando dall’invisibilità alla consapevolezza, dalla timidezza al potere.
Nei film ambientati in altre epoche, la moda diventa parte viva del racconto. In Il grande Gatsby (1974 e 2013), i completi bianchi, le frange, i ricami e i gioielli art déco incarnano l’ebbrezza dorata e la fragile illusione di felicità dei ruggenti anni Venti. In Marie Antoinette (2006) di Sofia Coppola, i costumi pastello di Milena Canonero diventano metafora visiva di giovinezza, eccesso e decadenza, anticipando la caduta della regina e trasformando l’abito in vero strumento narrativo.
Anche nel cinema contemporaneo, la moda resta una chiave di lettura culturale. In Barbie (2023), ogni outfit indossato da Margot Robbie veicola un messaggio ironico e vivace sull’identità, sull’immagine femminile e sulla libertà di essere se stesse.
In tutti questi casi, gli abiti non sono semplici accessori di scena, ma parole di stoffa che raccontano emozioni, sogni e contraddizioni sociali. Sono simboli e memorie capaci di attraversare il tempo, narrando epoche, rivoluzioni silenziose e desideri collettivi. Attraverso il cinema, la moda continua a vestire non solo i corpi, ma anche le aspirazioni di chi osserva, con la forza di un’immagine e la leggerezza di un tessuto.
L’influenza reciproca tra passerella e schermo
Moda e cinema, quindi, si parlano attraverso ispirazioni, rimandi e reinterpretazioni costanti. Fin dagli anni ’50, grandi maison come Christian Dior e Balenciaga hanno vestito le star, trasformando gli attori in ambasciatori di stile e portando l’alta moda sotto i riflettori di Hollywood. Gli abiti delle dive non erano più solo costumi: diventavano manifesti di stile capaci di determinare tendenze in tutto il mondo, creando un circolo virtuoso tra cinema e industria della moda.
Negli anni ’80 e ’90, il legame si rafforza ulteriormente. Stilisti come Giorgio Armani, Versace e Dolce & Gabbana collaborano con registi e attori per creare look iconici. I completi di Armani indossati da Richard Gere in American Gigolo (1980) rivoluzionano l’immagine dell’uomo moderno: elegante, disinvolto e seducente, ridefinendo la mascolinità attraverso la moda e modificando l’abbigliamento maschile per decenni.
Oggi, questa collaborazione è più viva che mai: Prada firma i costumi di The Great Gatsby e Il diavolo veste Prada, Chanel lavora spesso con registe come Sofia Coppola, e Gucci porta la propria storia sul grande schermo con House of Gucci (2021). Ma l’influenza non è mai a senso unico: anche il cinema detta legge sulla moda. Dopo Matrix, lo stile cyberpunk ritorna sulle passerelle di Balenciaga e Rick Owens, mentre dopo Barbie (2023) il “Barbiecore”, dominato dal rosa acceso, conquista i social, dimostrando che quando moda e cinema si incontrano, il risultato è spettacolare, dinamico e contagioso.
Lo stile che racconta storie
La moda nel cinema non è mai solo apparenza: è un modo per esprimere identità e conservare memoria collettiva. Ogni abito sullo schermo racconta una storia, diventando specchio di un’epoca che continua a parlare anche anni dopo. Dal tubino nero di Audrey Hepburn ai costumi futuristici di Black Panther o Dune, gli abiti cinematografici ispirano, dettano tendenze e riflettono chi siamo o chi sogniamo di diventare.
In fondo, un film può finire, ma uno stile davvero iconico resta per sempre, continuando a modellare culture, orientare la moda e plasmare i sogni di milioni di spettatori in tutto il mondo.
©Riproduzione Riservata
Emanuela Giuliani